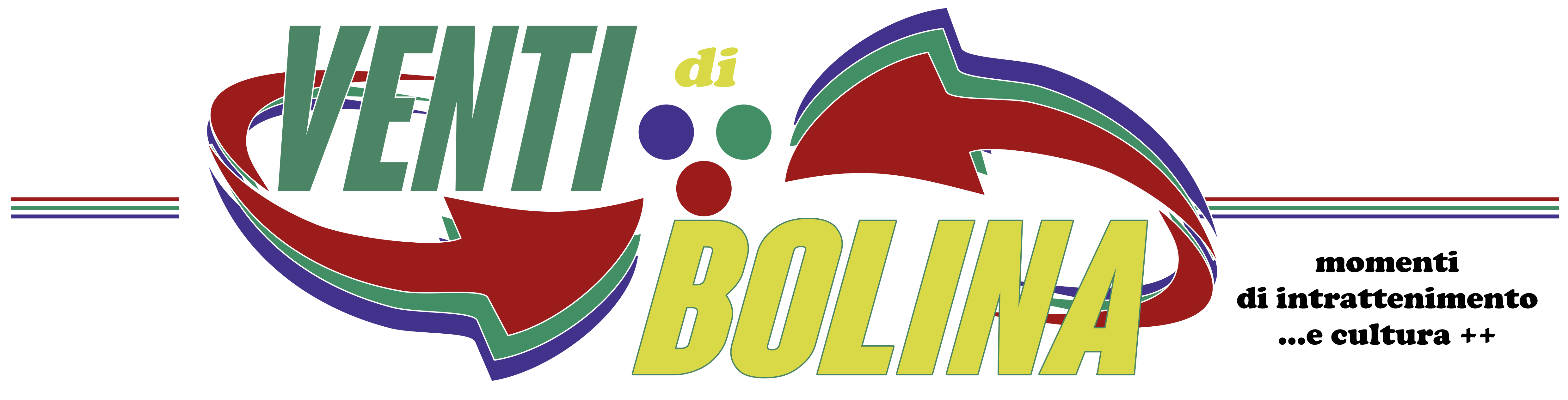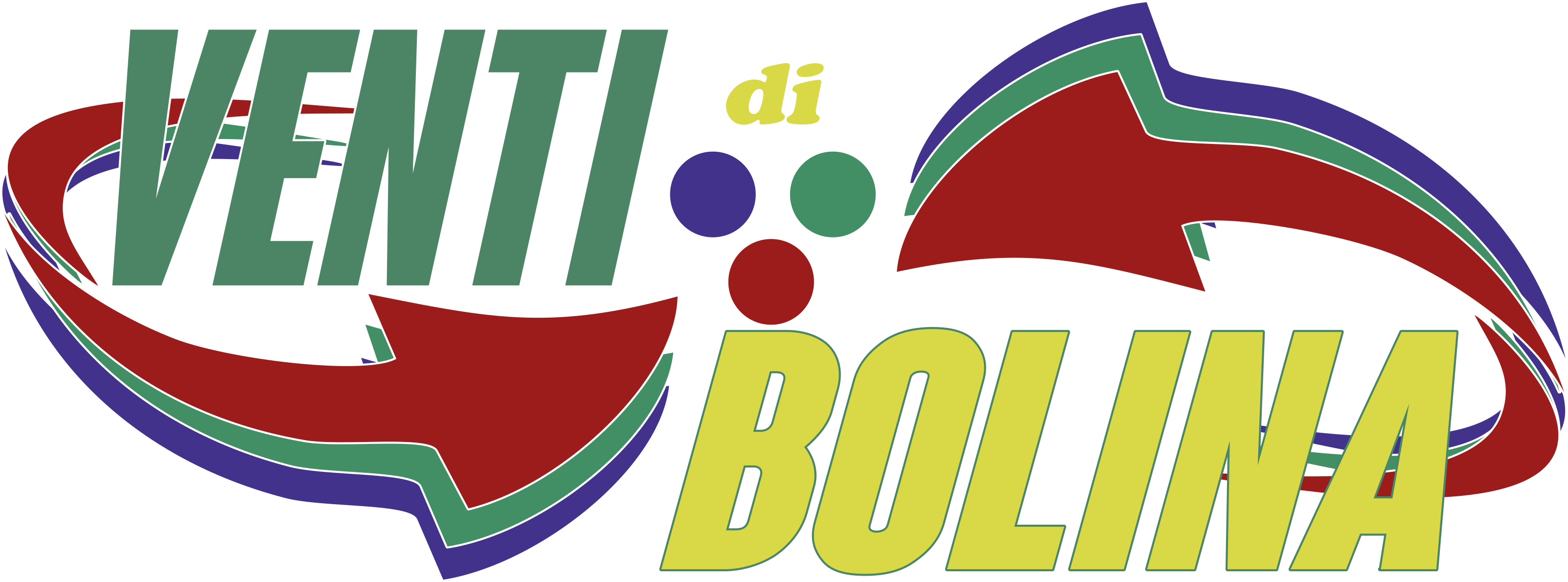Il fenomeno non è nuovo, ma l’avvento dei cosiddetti social media lo ha amplificato. Perché se prima erano i giornali e le televisioni a metterlo in atto, adesso qualunque utente di una piattaforma digitale può commentare, insultare, puntare il dito, scagliare clave virtuali che fanno male quanto e più di quelle fisiche. Victim blaming, colpevolizzazione della vittima o vittimizzazione secondaria che dir si voglia, è la pratica per cui si tende a ritenere la vittima di un crimine parzialmente o interamente responsabile di ciò che le è accaduto e spesso nell'indurre la vittima stessa ad auto colpevolizzarsi. Sempre più spesso oggi si utilizza il concetto di victim blaming in riferimento a casi di stupro e violenza di genere, ma il fuoco di questa nostra riflessione non vuole concentrarsi – soltanto – su questo fenomeno che definire deprecabile è un eufemismo edulcorato come un dolcificante che fa più male che bene.
Sfogliando la tesi di laurea in psicologia della dott.ssa Eleonora Gentile si apprende che “il termine victim blaming sta ad indicare letteralmente il ‘biasimo della vittima’, ossia quel meccanismo tramite il quale viene attribuita parte della colpa anche alla vittima e non totalmente al colpevole. L’espressione fu coniata dallo psicologo William Ryan nel 1971 nel suo libro intitolato ‘Blaming the victim’. Nel testo, l’espressione victim blaming indicava la tendenza a incolpare per la loro stessa condizione le persone in stato di povertà e indigenza”. Prima di affrontare i danni che tale pratica può provocare nella psiche e nella vita stessa della vittima, ci chiediamo cos’è che spinge la società a mettere in pratica un meccanismo che tende a distorcere la realtà dei fatti, spostando l’attenzione su eventuali presunte colpe di chi subisce, attenuando di fatto quelle di chi infligge dolore, che sia fisico o psichico, fino anche a portare alla morte? “Un concetto molto importante per la psicologia sociale è quello della percezione sociale, ossia lo studio del modo in cui creiamo impressioni e formuliamo giudizi riguardo agli altri – continua la tesi della dott.ssa Gentile - Spesso gli individui cercano di comprendere una situazione esterna facendo ricorso alle poche informazioni disponibili che hanno e ciò li induce a formulare credenze sbagliate o non vere. Anche il fenomeno del victim blaming può essere spiegato in questi termini. Lo si può definire come un errore percettivo con cui, cercando di spiegare e capire rapidamente l’episodio di violenza che hanno davanti, ci si affida alle poche informazioni disponibili e alle credenze preesistenti rispetto alla violenza, finendo per percepire la vittima come responsabile della violenza stessa”.
Se poi la stampa ufficiale si prodiga nel fornire informazioni sul passato e sull’attività sociale della vittima, dandola in pasto all’opinione pubblica senza applicare adeguati filtri, anzi amplificando ed enfatizzando alcuni aspetti, ecco che la percezione del ricevente coglie messaggi che possono deviare dalla realtà dei fatti. Gli avvocati parlano di “verità processuale” che non sempre coincide perfettamente con la “verità dei fatti”, in quanto in tribunale devono andarci prove certe e dati di fatto concreti e tangibili. Ma l’utente medio dei social, guidato spesso dalla ricerca del sensazionalismo mediatico, va ben oltre entrambe queste verità, e costruisce un quadro in cui, in un certo senso, colpevolizzando la vittima tende a esorcizzare la violenza dalla propria vita: “a me non può accadere, perché io non faccio quello che ha fatto la vittima”. Nei casi di stupro e di violenza si usano frasi “com’era vestita”, “aveva bevuto troppo”, “perché ci è andata”, negli omicidi e nelle violenze fisiche entrano in gioco l’esasperazione che la vittima avrebbe indotto nel suo aggressore, e non c’è bisogno di elencare tutte le giustificazioni che si adducono ad attenuare la colpa di chi è davvero colpevole, scaricando le cause su presunti comportamenti delle vittime.
Ma cosa provoca nella vittima questa pratica di addossarle parte della colpa, almeno quando è sopravvissuta al fatto violento? “Il fenomeno della vittimizzazione secondaria ha conseguenze estremamente negative sulla vittima che si sente ancora di più emarginata, stigmatizzata”. Questa “seconda aggressione”, può essere operata a volte anche dalle cosiddette "agenzie di controllo", cioè medici e sanitari, polizia, avvocati e magistratura, che possono non credere alla versione della vittima e accusarla di avere provocato l'aggressione, e ciò provoca un indebolimento dal punto di vista processuale, innanzitutto, e psicologico, ovviamente. Anche i mezzi di comunicazione di massa, come già detto, possono causare una "vittimizzazione secondaria", per esempio pubblicando la foto e il nome della vittima, esponendola all'opinione pubblica senza nessuna etica, oppure insinuando che la denuncia sia una calunnia senza attendere il verdetto del tribunale.
La deontologia professionale del giornalista prevede, tra le altre cose, la “sospensione del giudizio” (questa sconosciuta, nda), ovvero “l'astensione da un determinato giudizio o valutazione, qualora non risultino disponibili sufficienti elementi per formulare il giudizio stesso”. Troppo spesso, invece, anche e non solo per applicare la tecnica del cosiddetto clickbait (acchiappa click, per incassare i proventi delle inserzioni pubblicitarie), si disattende all’altra regola aurea che prevede di “utilizzare un linguaggio esatto e libero da pregiudizi. Ad esempio, uno stupro o un tentato stupro non possono venire assimilati ad una normale relazione sessuale […] I giornalisti dovrebbero riflettere sul grado di dettagli che desiderano rivelare. L'eccesso di dettagli rischia di far precipitare il reportage nel sensazionalismo. Così come l'assenza di dettagli rischia di ridurre o banalizzare la gravità della situazione. Evitare di colpevolizzare in qualche modo la persona sopravvissuta alla violenza (‘se l'è cercata’) o di far intendere che è responsabile degli attacchi o degli atti di violenza subiti”, continua la dott.ssa Gentile. Tale atteggiamento, nell’era del post libero sulle piattaforme digitali, non fa altre se non indurre l’utente medio a continuare su quella scia, lasciandosi andare a commenti e frasi che, a volte, definire violente equivale a dire che Jack lo squartatore fosse un semplice abile utilizzatore della strumentazione da macellaio applicata però agli esseri umani.
Quali possono essere quindi le conseguenze della vittimizzazione? Sul piano psicologico possono essere molto gravi, e spesso lo sono, provocando timore, senso di impotenza, scarsa autostima, persino depressione e perdita di fiducia negli altri e nelle istituzioni. Possono far imboccare alla vittima un tunnel senza uscita, in fondo al quale a volte, e ci sono fatti di cronaca, anche locale, che lo testimoniamo, c’è il suicidio, o comunque l’annientamento parziale o totale della dignità stessa della persona, che dovrebbe essere, anzi lo è, uno dei pilastri su cui si fonda la libertà. Se non c’è dignità, non può esserci libertà. E se poi in un Paese civile, a Terzo Millennio ormai ampiamente avviato, in un’epoca in cui si parla di Intelligenza Artificiale, sviluppo sostenibile, e grandi concetti altisonanti vari ed eventuali, deve essere un imprenditore e attore dell’industria del porno a stigmatizzare l’abuso della pornografia e a chiederne la limitazione in rete, davvero c’è da preoccuparsi: è come se l’amministratore delegato della più grande impresa di distribuzione alimentare di carne e derivati chiedesse all’umanità di diventare vegana, o come se l’ideatore dei social media chiedesse alla gente di tornare a comunicare con i segnali di fumo o con l’alfabeto Morse (a conoscerlo…). In una società così articolata e complessa come quella in cui siamo ormai immersi e sommersi, forse sarebbe il momento di mettere da parte ideologie e senso di appartenenza a questa o quella parte del mondo, troppo spesso visualizzato come se fosse diviso in due parti contrapposte tra loro.
Ci vengono in mente due frasi. Il primo, legato alla comunicazione, è un aforismo che conclude la tesi più volte citata: “Non possiamo sperare che la società cambi se il modo in cui viene raccontata resta sempre lo stesso” (Guerra, 2019)”. La seconda, che circola spesso, anche a proposito, sul web, è dello scrittore russo Tolstoj: “tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare sé stesso”.
Matteo Gentile