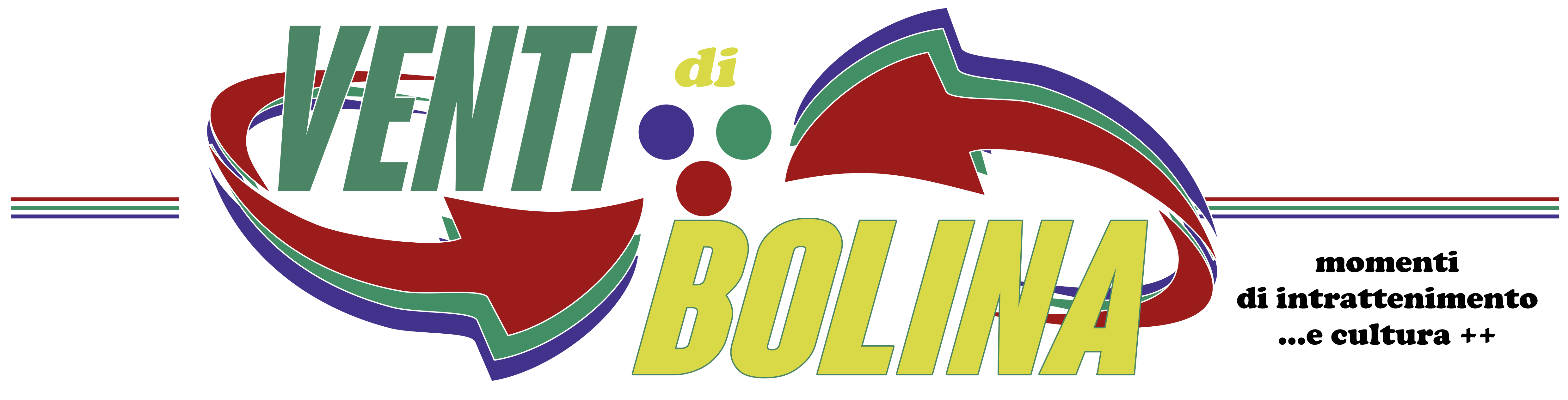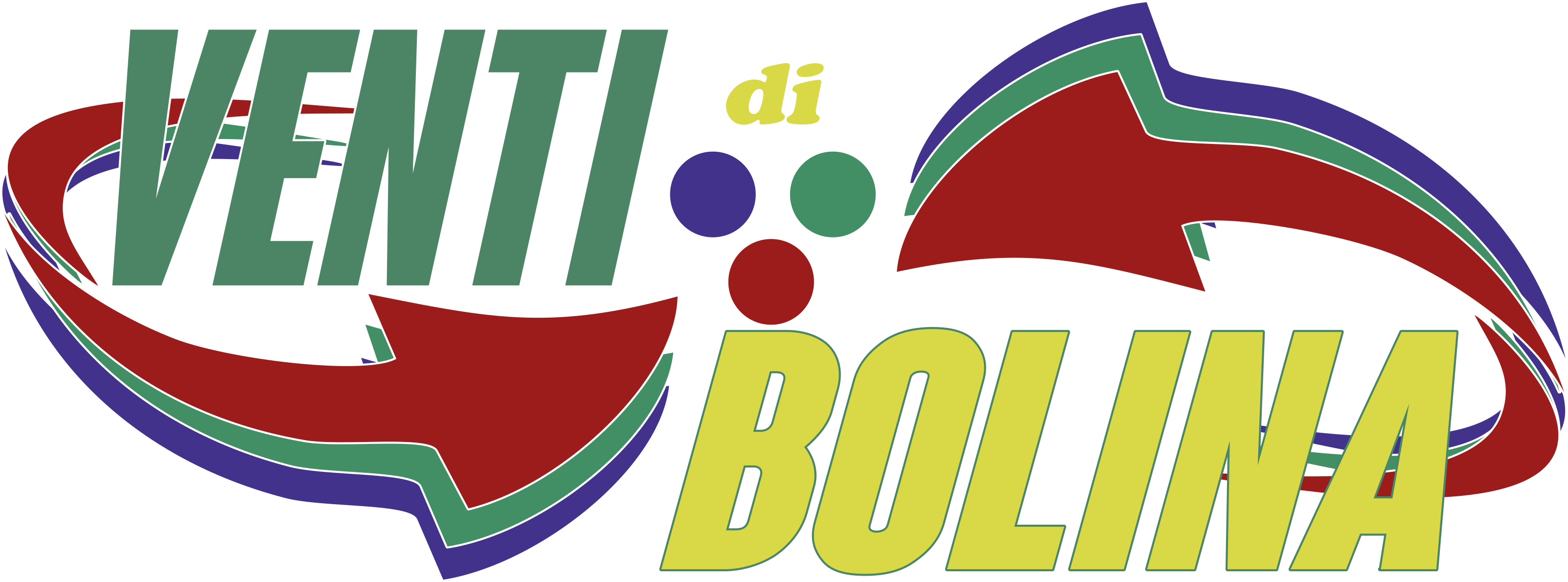“Corpi celesti”, nella pregevole traduzione dall’arabo di Giacomo Longhi, scritto dall’omanita Jokha Alharti e pubblicato nel 2010, trae il titolo da una definizione di Khalid nel dialogo con la moglie Asma’, a proposito della leggenda dell’anima divisa in due. Una teoria che riecheggia l’intervento di Aristofane nel Simposio di Platone, quando egli definisce Eros come ricongiunzione dell’essere primigenio diviso in due metà dal padre degli dei Zeus per punire la tracotanza e l’indifferenza umana che avevano trascurato i sacrifici.
L’esistenza è la ricerca continua dell’altra metà che si realizza grazie all’impulso amoroso. Secondo un’antica leggenda contenuta nel libro antico “Il collare della colomba” di Ibn Hazm, Khadid le ricorda che in principio gli esseri umani erano tutti figli della luna, di un unico genere, maschile e femminile, con quattro mani, quattro gambe e due teste. Da qui il titolo originale Sayyidat al-qamar (Le signore della Luna). Asma’ invece si convince che le persone non sono entità incomplete in cerca della loro metà mancante e che né i corpi né le anime sono divise in due. E neppure che due persone possano a livello spirituale combaciare perfettamente. In ogni caso non è lei la metà che Khalid diceva di aver ritrovato.

Questa asimmetria fra la tensione artistica e affettiva di Khalid e la consapevolezza e conquista dell’autonomia da parte di Asma’ la spingono a definire una sua sfera, come un pianeta con un’orbita tutta sua, indipendente da quello di Khalid. Il romanzo di Jokha Alharthi, nata nel 1978, premiata nel 2019 con il Man Booker Prize International, l’unica autrice araba finora ad averlo vinto, intreccia attraverso le vicende di tre sorelle: Mayya, la maggiore, che sposa ‘Abdallah, seguendo il volere della famiglia, senza mai viverlo come un amore appassionato, Asma’ che predilige la letteratura e che intravede nell’artista Khalid la possibilità di uscire dalla noiosa quotidianità del piccolo paese di ‘Awafi, e infine la bellissima Khawla, la minore, che non vuole sposarsi e vorrebbe vivere in maniera indipendente ma i suoi sogni si spezzano dopo aver ceduto a Nasir, che la ingravida ogni volta che torna dal Canada, dove lavora e soprattutto ha costruito una relazione con una giovane la cui immagine tiene in bella vista come trofeo nel porta chiavi. Khawla troverà la forza di divorziare non per il comportamento attuale premuroso di Nasir, ma perché quando ha avuto bisogno di affetto lui non c’era mai. Un percorso difficile e accidentato che ci riporta le vicende di un paese antico e glorioso – il califfato dell’Oman si estendeva sino a comprendere le coste orientali dell’Africa e la capitale di Mascate era al centro dei traffici commerciali delle spezie fra l’Occidente e l’India, una navigazione che si serviva degli alisei o monsoni che sospingevano le imbarcazioni onuste di carichi preziosi. “A seafaring nation” viene definito l’Oman, alle prese con uno sviluppo vertiginoso che taglia i ponti con la tradizione.
Questo passaggio delicato è vissuto come una situazione instabile tra la tradizione e i nuovi bisogni di una classe di professionisti, uomini e donne, che hanno studiato e hanno nuove esigenze, ma rischiano di perdere l’anima. L’emblema di questa situazione è rappresentato da ‘Abdallah, l’unico narratore in prima persona, che ha vissuto la crisi del rapporto autoritario paterno e che ora è disilluso non riuscendo ad orientarsi fra il passato di cui è impregnato e i nuovi bisogni della società. Si può capire come tutta la materia narrativa incandescente abbia non sempre trovato accoglienza favorevole in patria, anzi a volte anche ostilità.
Ma Jokha Alharthi, che ha perfezionato gli studi ad Edimburgo e che ora è docente di letteratura araba alla Sultan Qaboos University di Mascate, è consapevole che bisogna fare i conti con le nuove necessità di una società moderna che senza rinnegare il passato e la tradizione, anzi valorizzandoli, sappia trovare la strada per andare oltre. Giunti Editore/Bompiani, Firenze-Milano 2022, pp. 258.
Paolo Rausa